Leggi anche la prima parte e la terza parte.
Di solito all’Aquila si esce il giovedì e il sabato sera. È in quei giorni che ci si ritrova “al centro”, per una birra, un gelato, o semplicemente “pe’ fasse ‘nu giro”, che poi ognuno suggella come vuole. Stasera invece è mercoledì, e con altri quattro ex compagni del liceo abbiamo deciso di rivederci dopo un paio di mesi, e aggiornarci a vicenda sugli ultimi avvenimenti. Proprio per questo si è optato per il mercoledì: evitare la folla e starcene un po’ tranquilli.

Foto: Giancarlo Malandra, da “La città negata“
Ci ritroviamo alla Villa Comunale, una delle zone più belle della città prima del terremoto, a metà strada tra Piazza Duomo e la basilica di Collemaggio, e ora alquanto malconcia: i giardini, quasi sempre deserti, sono piuttosto spelacchiati, con chiazze di terra brulla che si dilatano come una cancrena silenziosa; anche i sampietrini dei viali in mezzo alle aiuole sono sempre più dismessi, sempre più numerose le falle e le toppe provvisorie usate per coprirle. Tutto sembra denunciare un lento disfacimento. O forse sono io che mi convinco di vedere questa corruzione negli oggetti, nelle cose che mi circondano, come il riverbero di una pervasiva precarietà che percepisco intorno a me; probabilmente quella stessa incuria, quelle stesse fastidiose imperfezioni nel verde pubblico, c’erano anche prima del terremoto, ché certo L’Aquila neppure allora era una città troppo ben tenuta. Eppure in passato tutto ciò lo notavo appena e proseguivo, mentre adesso avverto quasi l’esigenza di soffermare lo sguardo su un qualcosa di concreto che funga da correlativo di quel senso di malsana inquietudine che mi si incrosta in un punto imprecisato dello stomaco.
Al centro del parco il monumento ai caduti, con una Nike alata che rasenterebbe il ridicolo, con la sua fascista posa trionfale, se non fosse per una certa espressione di pietà che ne ammorbidisce i tratti del volto. Pochi mesi fa, una donna si incatenò lì sotto. La ditta edile che stava ristrutturando il suo appartamento danneggiato dal sisma aveva contratto dei debiti nei confronti di una ditta appaltante, e così tutto il palazzo era stato pignorato: col risultato che i lavori vennero sospesi e la sua speranza di rientrare nella sua casa, a quattro anni dal 6 aprile 2009, si sgretolò di nuovo. Assurdità non infrequenti, nell’Aquila del dopoterremoto.
Da circa un paio d’anni di ravvivare la vuotezza della Villa Comunale si sforza una manciata di botteghe di oggettistica ed artigianato, costrette in delle cabine di legno che ricordano un po’ quelle degli stabilimenti balneari, all’interno delle quali i commercianti – rigorosamente uno per cabina – si muovono con malagrazia. Questo di giorno; la sera, soltanto un bar resta aperto. Decidiamo di entrare per bere qualcosa, ma lo troviamo desolatamente vuoto. Il titolare, seduto ad uno dei tavoli vicino alla televisione, sonnecchia davanti alla semifinale della Confederations Cup tra Brasile e Uruguay. Solo quando il ragazzo che sta dietro al bancone, che è anche lui un nostro vecchio compagno del ginnasio, ci saluta, svogliatamente il proprietario si ridesta; si alza, fa finta di spolverare un po’ il tavolo, ci fa un cenno con la testa che non si capisce se è di benvenuto o di irritazione, poi torna a sedersi davanti alla televisione. Sobbalzerà nuovamente all’urlo del telecronista per il gol del 2 a 1 del Brasile, mentre noi stiamo pagando alla cassa.
Risalendo Corso Federico II, ci avviciniamo a Piazza Duomo. Si parla dell’università, di un nostro amico che all’ultimo momento non ha potuto raggiungerci, dei progetti per l’estate.
«Ma quand’è che hanno tolto il coso di metallo?» chiede Elena, con una voce carica di sorpresa.
«Quale coso?» ribatte Gianmarco.
«Dai, su, quell’ambaradan di tubi…», precisa ancora Elena, riferendosi ad un’impalcatura di sostegno metallica, montata dai Vigili del Fuoco, che formava una sorta di tunnel sotto cui si era costretti a passare, e che deve esser stata rimossa da poche settimane.
«Ah, è vero… Non me ne ero mica accorta che l’avevano tolto», dice Cristina.
Ci guardiamo in faccia con aria interrogativa: nessuno, in effetti, se ne era accorto.
In Piazza Duomo non c’è nessuno. E anche questa non è un’iperbole: non c’è davvero nessuno. L’unico segno di vita è costituito dal rumore imperterrito dell’acqua delle fontane, che di solito – ma non stasera – è coperto dalla musica diffusa dagli altoparlanti di un bar in fondo alla piazza. Fu uno dei primi locali a riaprire in centro, subito dopo il restringimento della zona rossa; doveva essere inverno, perché mi ricordo che c’era un freddo insostenibile quando ci andai con un paio di amici. Fuori dal bar era stato allestito un gazebo di legno che lasciava penetrare degli spifferi tremendi, e per riscaldare c’erano un paio di stufe a fungo, che però non funzionavano, o quantomeno non funzionavano abbastanza, perché l’immagine più nitida che conservo di quella sera siamo tutti noi intirizziti intorno a un tavolo, con i cappucci tirati sulla testa, il collo rinserrato nelle spalle e le mani attorno alle tazze di cioccolata calda fumante. Però fu una serata bellissima: tornare a bere qualcosa in Piazza Duomo dava un senso di serenità semplice e pulita.
Continuiamo a camminare lungo il Corso deserto. Arriviamo davanti alla Fontana Luminosa, ci fermiamo un attimo e torniamo indietro lungo la stessa strada; nei momenti in cui la discussione si spegne, distinguiamo chiaramente il rumore della ghiaia sotto le suole delle nostre scarpe. In tutto il tragitto incrociamo – le ho contate – ventidue persone, compresi sei militari, le cui divise mimetiche, insieme alle camionette con dei lunghi antennoni flessibili, sono ormai diventate parte integrante del panorama del centro cittadino. Il loro compito, ufficialmente, è quello di presidiare le zone interdette al traffico, e di evitare che degli “sciacalli” si introducano in palazzi abbandonati onde sottrarre dagli stessi oggetti vari, al fine di impossessarsene e trarne profitto, per sé o per altri, tramite atto qualificabile come furto, e pertanto perseguibile a norma di legge. In realtà la loro è diventata, agli occhi di tutti gli Aquilani, una mera funzione scenografica, nonostante le autorità si ostinino a ribadire l’assoluta indispensabilità del ruolo da loro svolto.
Li trovi puntualmente negli stessi punti, cioè nelle principali vie d’accesso al centro storico, che poi sono quattro o cinque. D’estate se ne stanno lì, impalati per ore, il peso del corpo che passa da un piede all’altro, a osservare distrattamente i passanti, con un’aria che varia dall’indifferenza al disprezzo; due camionette per presidio, due militari per ogni camionetta. Quasi sempre in ogni gruppo c’è almeno una donna. Da ottobre ad aprile, invece, è assai probabile vederli attraverso il parabrezza dei loro veicoli, soprattutto di sera, perché stare fuori, perlopiù immobili, tra ottobre e aprile, a L’Aquila significa rischiare il congelamento. Per questo, prudentemente, preferiscono passare la maggior parte del tempo in macchina, davanti alle bocchette dell’aria calda; il che però li costringe a tenere costantemente acceso il motore, per non scaricare la batteria, cosicché per decine di metri si respira puzza di monossido. Se passi da solo, specie se ad ora tarda, davanti ad una delle camionette, capita che ti senti a disagio, e cerchi di accelerare per abbreviare quello strano senso d’impaccio, ma al tempo stesso ti sforzi di assumere l’andatura più regolare possibile, per fugare ogni eventuale sospetto. Non è che i militari perquisiscano ogni individuo dall’andatura traballante, ma è che loro non hanno nulla da fare, e dunque inevitabilmente finisci con l’essere scrutato: per qualche secondo sei il loro diversivo alla noia. Del resto quasi sempre l’imbarazzo dura appena pochi passi, poi evapora; solo due volte, invece, mi è successo di sobbalzare davanti alle camionette. È accaduto in entrambi i casi perché, coi lampioni danneggiati che emanavano una flebile luce intermittente, un gendarme particolarmente zelante pensò bene di puntarmi addosso gli abbaglianti della sua camionetta mentre io mi avvicinavo. Ma anche in quel caso, tutto si risolse in un’occhiata prolungata e poco cortese.
Del resto i primi ad essere scarsamente convinti dell’utilità della loro funzione sembrano essere proprio i militari. Sui loro volti vedi spesso indolenza e apatia: parlottano, si girano una sigaretta, i più audaci – o i meno ligi alla disciplina, non saprei – arrischiano anche un improbabile approccio con qualche ragazza. Ma perlopiù sembrano limitarsi a contare i minuti che passano, e ad ignorare quanto accade intorno a loro. Sanno benissimo che la loro presenza non potrà impedire che qualcuno, stasera come ogni altra sera, oltrepasserà le fatiscenti transenne che delimitano la zona rossa, in uno dei tanti vicoli che ancora, dopo quattro anni, restano sigillati nel buio e nell’incuria più totale.
Si “entra in zona rossa” per tanti motivi: per fumare in tutta tranquillità, per appartarsi con una ragazza, per tornare in una strada o davanti un palazzo ai quali si è affezionati e che si rischia di veder scolorire nella propria memoria, oppure per il semplice piacere di violare un divieto, che nella fattispecie significa anche ribadire il diritto a riappropriarsi di spazi che si sentono come propri.
L’ultima volta che mi è capitato di entrare in zona rossa è stato l’inverno scorso, poco dopo Natale. Era un pomeriggio non troppo freddo, un mio amico musicista suonava in un locale in centro, e mi aveva invitato ad andarlo ad ascoltare. Essendo in evidente anticipo, decisi di farmi una passeggiata: mi ritrovai quasi senza volerlo davanti al mio vecchio liceo, il Liceo Classico “Domenico Cotugno”, che dal 2006 era stato trasferito nella nuova sede di Palazzo Quinzi, antica residenza di una delle più nobili famiglie aquilane fatta ricostruire dopo il terremoto del 1703 (sono stati quasi sempre i terremoti, d’altra parte, a scandire l’evoluzione architettonica e urbanistica della città: 1461, 1703, dopo ogni sisma nuovi monumenti, nuovi stili; dopo il 2009, chissà). “È un palazzo assolutamente sicuro, anche in virtù del fatto che sorge su una zona di sedimentazione che ne garantisce una relativa stabilità” – ci aveva tranquillizzato la professoressa di biologia. La notte del 6 aprile mancò poco che si sbriciolasse. I giornali, locali e nazionali, parlarono del “miracolo di Palazzo Quinzi”, ché grazie a degli interventi di ristrutturazione preventiva si erano contenuti i danni, i quali altrimenti sarebbero stati molto più gravi; sta di fatto che nelle stanze che ospitavano gli uffici della presidenza s’era aperta una voragine, quelle in cui era stato allestito il laboratorio di scienze erano anch’esse disastrate, una parte del solaio dell’ultimo piano era crollato, assieme alle volte sopra le scalinate. Se il terremoto fosse avvenuto alle 10 del mattino, anziché alle 3 di notte, sarebbe stata una carneficina.
Provai a spostare le transenne che impedivano l’accesso in Via San Martino, la via adiacente all’ala est del liceo: si mossero senza alcuna resistenza. Mi aprii un varco e passai. Sapevo che la parte più danneggiata del palazzo era quella opposta all’entrata principale, e mi prese la curiosità di andare a vederla. Fu piuttosto desolante: larghe feritoie, disegnando delle bizzarre curve, fendevano la parete in tutta la sua altezza, e il tetto, in corrispondenza dell’angolo in alto, completamente crollato, si piegava in maniera irregolare. Lì vicino la carcassa di una macchina – una Smart, si indovinava un po’ a fatica – stava sepolta sotto il peso di alcuni massi che le erano caduti sopra, sfondando completamente tettuccio e parabrezza, e costringendo il tubo di scarico a schiacciarsi contro i sampietrini. Nel piccolo cortile posteriore del palazzo doveva esser stato allestito un cantiere edile, che però dimostrava d’esser stato abbandonato all’improvviso: c’erano degli strumenti da lavoro lasciati incustoditi, dei guanti, dei sacchi di calce aperti, delle carriole semirovesciate ancora incrostate di cemento. Attraverso le inferriate del cancello vidi che alcune porte di quelli che sapevo essere i magazzini del liceo erano aperte. Scavalcai. Entrando in una delle stanze, fui assalito da un odore acre, come di formaggio andato a male; sfruttando la poca luce del pomeriggio invernale, che riusciva a stento a rischiarare la stanza, cominciai a rovistare all’interno di alcuni scatoloni, e scoprii che contenevano cataste di compiti in classe, rilegati con delle fascette di carta. Accanto, c’erano delle grosse cartelle blu, chiuse con degli spaghi piuttosto grossolani, e su ognuna di esse erano indicati il nome della classe e l’anno scolastico in corso. Ero entrato nell’archivio. Scartabellando alla rinfusa i fasci di verifiche nei vari scatoloni, trovai anche quelli della mia classe: sentivo di tremare di un’indistinta emozione, mentre continuavo a toccare quei fogli che in tutt’altre circostanze, ma in quello stesso palazzo, dovevano esser già passati tra le mie mani, e che ora la muffa se li mangiava, e si faceva fatica ad aprili, tanto l’umidità li aveva incollati gli uni agli altri. Pochi giorni dopo raccontai tutto alla mia ex professoressa di inglese; non volle credermi: mi disse che due anni prima aveva fatto richiesta di poter recuperare alcuni documenti di cui aveva bisogno, e che le era stato detto, se lo ricordava bene, che era pericoloso entrare nell’archivio, e che solamente con l’ausilio dei vigili del fuoco sarebbe stato possibile, ma poi erano passati mesi e mesi e la richiesta era caduta nel vuoto.
Intanto eccoci tornati alla Villa Comunale, proprio dove ci eravamo incontrati. Ed è lì che ci salutiamo. “Dai – sorride Cristina – rivediamoci sabato. Il mercoledì è un po’ una mortificazione, perché in effetti non ci sta niente da fare. Ma il giovedì e il sabato è diverso”.
Leggi anche la prima parte e la terza parte.
di Valerio Valentini, da quattrocentoquattro.com
http://quattrocentoquattro.com/2013/07/25/vivere-e-raccontare-laquila-giugno-2013-seconda-parte/
quest’opera è sotto licenza Creative Commons






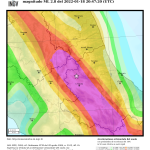









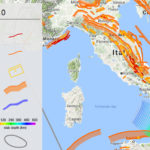



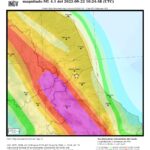



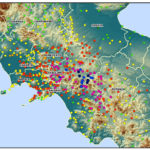
 6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.
6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.
6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.